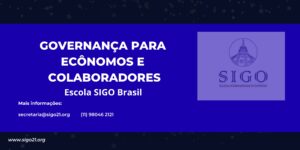MAGISTERO DELLA CHIESA (I):
IL SERVIZIO DELL’AUTORITÀ NELLA VITA CONSACRATA.
Dal Vaticano II alla vigilia della “Faciem Tuam”
In primo luogo, è difficile parlare del servizio dell’autorità nella Vita Consacrata in genere, visto che “in genere” essa non esiste (cf. PI nn. 16, 17; VFC n. 46); esistono i vari gruppi o Istituti e, in fin dei conti, i singoli religiosi. Il Magistero, invece, parla in genere: ecco il bisogno di inquadrare e interpretare quanto ci venga detto, secondo i vari carismi. Pretendere di applicare tutto a tutti, come se fossimo tutti uguali, non sarebbe obbedienza perfetta, ma semplicemente confusione. Quindi, quanto sto per dire va riletto e tradotto secondo il proprio carisma e missione.
Quando si parla di autorità e obbedienza nella Vita Consacrata, quelli che siamo occidentali o più o meno occidentalizzati (e data la globalizzazione attuale lo siamo quasi tutti), tendiamo per cultura a capirla unicamente o soprattutto in senso sociologico-psicologico-giuridico; in una parola, “umano” e basta. C’è alle volte il rischio o di capire o di vivere questi rapporti in modo “ateistico”, cioè, prescindendo dalla fede; così facendo, però, non faremmo altro che uscire proprio dall’ambito specifico della Vita Consacrata. Essa, infatti, non è un fatto semplicemente organizzativo, ma di fede.
Inoltre,, non si può capire il senso dell’autorità senza vederla nel contesto della comunione carismatica che, nella Vita Religiosa, si realizza nella vita fraterna comunitaria in favore della missione. E, a sua volta, non si può capire la comunione nella Vita Consacrata senza vederla entro e come una delle manifestazioni (in se stessa plurima) della comunione ecclesiale. Come dice Giovanni, infatti, la fede cristiana non è altro che la rivelazione della nostra partecipazione in una comunione, la “koinonia” trinitaria:
“Quello che era dal principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato e che la nostre mani toccarono del Verbo della vita (…), quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo” (1Gv 1, 1-3; cf. Gv 17, 20-23).
Ecco l’importanza di avere sempre in mente quanto dice il VFC:
“Prima di essere una costruzione umana, la comunità religiosa è un dono dello Spirito. Infatti è dall’amore di Dio diffuso nei cuori per mezzo dello Spirito che la comunità religiosa trae origine e da esso viene costruita come una vera famiglia adunata nel nome del Signore (cf. PC n. 15a, CDC c. 602).
Non si può comprendere quindi la comunità religiosa senza partire dal suo essere dono dall’Alto, dal suo mistero, dal suo radicarsi nel cuore stesso della Trinità santa e santificante, che la vuole parte del mistero della Chiesa, per la vita del mondo” (VFC n. 8; cf. nn. 9-10, VC nn. 41-42).
Come dice VFC n. 2, la comunità religiosa partecipa dunque della visione della Chiesa, cioè: dalla Chiesa-mistero alla dimensione misterica della comunità religiosa, dalla Chiesa-comunione alla dimensione comunionale-fraterna della comunità religiosa, dalla Chiesa animata dai carismi alla dimensione carismatica della comunità religiosa, dalla Chiesa-sacramento di unità alla dimensione apostolica della comunità religiosa. La comunità religiosa non è che una cellula di questa comunione fraterna ecclesiale.
Infine, non ci soffermeremo in particolare sull’Istruzione “Faciem tuam, Domine, requiram” su “Il servizio dell’autorità e l’obbedienza” (11 Maggio 2008) -anche se non potremo evitare di farvi dei riferimenti, data la sua tematica specifica-, perché sarà oggetto di una apposita conferenza da parte di un altro Professore, sabato 12 Marzo 2011.